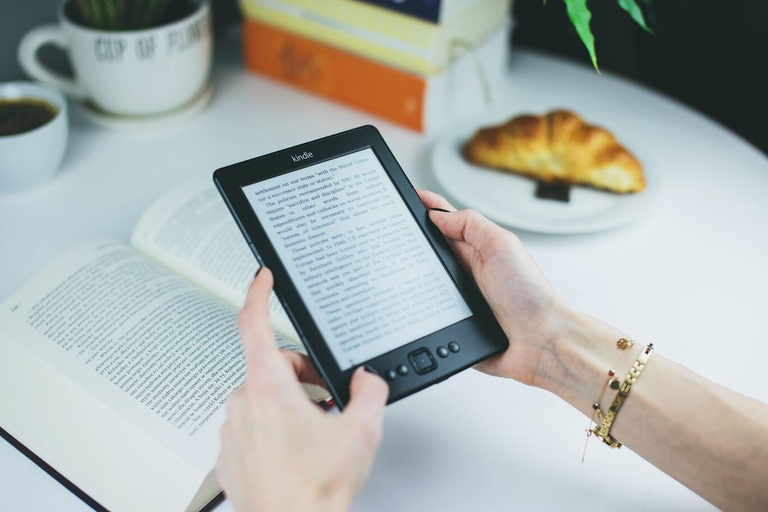Un nuovo modello diversifica i percorsi diagnostico-terapeutici tra uomini e donne affetti da patologie endo-diabetologiche: “Si risparmia e si curano più pazienti”.
Gli schermi offrono opportunità senza precedenti alla diffusione delle informazioni, ma incoraggiano anche la capacità di lettura superficiale. Dismettere la lettura profonda tipica dei testi stampati diminuisce pensiero critico e sensibilità sociale, confermando il legame esistente tra lettura ed empatia. Si sperimenta la soluzione di un cervello bi-alfabetizzato che prenda il meglio da lettura digitale
Quando Maryanne Wolf parla, sorride spesso. La ascolti citare autori di ogni epoca e provi invidia per gli studenti che seguono le sue lezioni al centro di dislessia, apprendimento inclusivo e giustizia sociale della Ucla a Los Angeles. Prima di iniziare l’intervista su Zoom, si alza e va a prendere un’illustrazione del Duomo di Milano: era la locandina di una serie di incontri in città, poi è diventata la copertina del suo ultimo libro “Lettore, vieni a casa”.
Un saggio originale per una neuroscienziata di fama internazionale, scritto in sei lettere accorate a partire da una domanda: il cervello che legge è in pericolo? La girandola dell’informazione digitale soffierà come un ciclone sul pensiero critico, l’immaginazione e l’empatia, tutti processi “lenti” tipici della lettura su stampa? In pratica, siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i romanzi: leggendo, scopriamo vite che non sono le nostre e impariamo ad accogliere nuovi punti di vista, capacità che insieme al saper “pensare al bene comune sono fondamentali nel buon cittadino democratico”, dice la filosofa Martha Nussbaum.
Lettura ed empatia: è un po’ come se leggere storie ci allenasse alla sintonia con gli altri…
Proprio così. Lettura ed empatia sono strettamente connesse. L’atto di assumere la prospettiva e le emozioni degli altri è uno dei contributi più intensi e meno riconosciuti della lettura profonda. Il racconto di Lucia Berlin, “Manuale per donne delle pulizie”, per me è un esempio tipico. Quando ho cominciato a leggerlo vedevo la protagonista, una donna delle pulizie, come una persona ignorante che non si accorgeva delle tragedie quotidiane che accadevano nei luoghi in cui lavorava. Finché sono arrivata all’ultima frase: “E finalmente piango”. Tutto quello che avevo supposto della donna, che è la voce narrante, con questa frase finale è volato fuori da una di quelle finestre che si aprono quando ci accorgiamo dei pregiudizi che ci portiamo dietro in ciò che leggiamo.
L’empatia è un processo mentale o emotivo?
Entrambi. Dal punto di vista della neuroscienza, esistono l’empatia cognitiva e quella emotiva, proprio come la narrativa è un incontro tra i nostri migliori pensieri e i nostri migliori sentimenti, che scopriamo uscendo da noi stessi. Quando leggiamo a livelli profondi ci spostiamo dal nostro punto di vista per forza di cose limitato sul mondo per immedesimarci in un altro e tornare in noi arricchiti. Leggere libri è parte dell’antidoto all’allontanamento dall’empatia, una capacità essenziale in un mondo di collegamenti aumentati tra culture divergenti.
La funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto diverso.
Cosa cambia se leggiamo sullo schermo?
La mente diventa una cavalletta, leggiamo con minore attenzione e abbiamo meno memoria, l’occhio scansiona rapidamente il testo per coglierne il senso generale: facciamo skimming (lettura superficiale) e questo mi preoccupa profondamente. Perché il nostro cervello è plastico e riflette la forma dei mezzi di comunicazione digitali, che premiano velocità e iperstimolazione. Quando siamo bombardati da troppe scelte la nostra reazione immediata può essere affidarci alle informazioni che richiedono un minore sforzo intellettivo.
Tendiamo a ritirarci verso le fonti di informazione più familiari, in cui ciò che già pensiamo sia “confermato” da prospettive simili. Questo potrebbe atrofizzare le nostre capacità analitiche e riflessive, fondamentali per una società realmente democratica, rendendoci vulnerabili alle fake news e alla demagogia in tutte le sue note forme. Nella guerra in Ucraina, ad esempio, vedo gli effetti pericolosi della disinformazione e, allo stesso tempo, l’aiuto straordinario che la tecnologia può dare nel connettere le persone tra loro anche in situazioni catastrofiche.
Quindi esiste un punto di incontro tra cultura digitale e stampata?
Si può fare esperienza della lettura profonda su diversi mezzi, ma va ricordato che ogni mezzo ha vantaggi e svantaggi. Tra l’accesso rapido a una quantità incredibile di informazioni e ciò che forma la nostra conoscenza vedo oggi una grande tensione, che per me può essere riconciliata solo attraverso il desiderio da parte degli esseri umani di plasmare i loro migliori pensieri e non vivere come anestetizzati nel pensiero “comodo” e nelle sue fonti. È un pezzo di umanità davvero importante quello che preserviamo mantenendo la nostra abilità di analisi critica delle informazioni e di leggere in un modo tale da imparare ad accogliere la prospettiva altrui. È facile dimenticare che la dimensione contemplativa che vive dentro di noi non è una cosa scontata, ma richiede tempo e volontà per essere alimentata.
Vale anche per i bambini?
Sono molto preoccupata per i piccoli lettori ma le soluzioni non mancano. Come ha scritto Alec Ross, autore de “Il nostro futuro”, il 65 per cento delle attività che bambini oggi alla scuola materna faranno in futuro non è ancora stato inventato. Stiamo studiando i limiti e le possibilità sia del circuito alfabetizzato sia di quelli digitalizzati e in questo scenario la mia proposta consiste nel supportare i bimbi a sviluppare un cervello bi-alfabetizzato, che nella mia esperienza ricalca le basi degli alunni bilingui. In pratica, nello stesso periodo in cui i bambini imparano a leggere e a pensare attraverso il mezzo più lento di libri e testi stampati, apprendono anche a pensare in modo complementare grazie, ad esempio, alla programmazione su dispositivi digitali, a smontare e costruire robot come sta già succedendo nel laboratorio di Cynthia Breazeal al Mit Media Lab.
È ora di salutarci, Maryanne Wolf ha un’altra videochiamata dall’Inghilterra. In cerca di una chiosa leggera per quest’intervista le strappo un consiglio per un libro: “The Resisters di Gish Jen”. Da leggere su carta, ovviamente.
Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.
![]()
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Un nuovo modello diversifica i percorsi diagnostico-terapeutici tra uomini e donne affetti da patologie endo-diabetologiche: “Si risparmia e si curano più pazienti”.
L’app di meditazione Petit BamBou lancia due nuovi programmi dedicati alla gravidanza consapevole e al mindful parenting.
Il contatto con la natura sarà parte integrante dei percorsi di riabilitazione per la salute mentale in Trentino: al via la montagnaterapia.
Riconoscere l’insieme per curare. Alla base della medicina olistica, l’identificazione di corpo, mente e spirito quali componenti di un sistema unificato.
Stanchezza e giramenti di testa fin dal mattino? Forse il problema è la pressione, troppo bassa per sostenere i ritmi lavorativi prima e dopo le vacanze.
Le piante tintorie hanno una lunga tradizione che si sposa bene anche nel campo dell’hair styling. Michele Rinaldi è il pioniere delle tinte vegetali per capelli, lo abbiamo intervistato.
Le microplastiche presenti nei cosmetici finiscono nei mari contribuendo all’inquinamento, ma esistono prodotti formulati senza polimeri.
“Troppo spesso la medicina tradizionale è stigmatizzata e liquidata come non scientifica. Ma per milioni di persone è semplicemente medicina”. Il senso del II° Congresso mondiale di salute e medicina integrata appena conclusosi a Roma è tutto qui, in una frase del Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesusche, pronunciata durante il suo videomessaggio inaugurale.
L’insonnia è un disturbo del sonno molto diffuso: in Italia ne soffrono circa 13 milioni di persone. Stress, preoccupazioni, predisposizione e abitudini di riposo scorrette contribuiscono all’insorgere dell’insonnia cronica. In prima linea per la cura di questa patologia la comunità scientifica schiera la terapia cognitivo-comportamentale. L’insonnia è molto più di un fastidio notturno. Nei casi