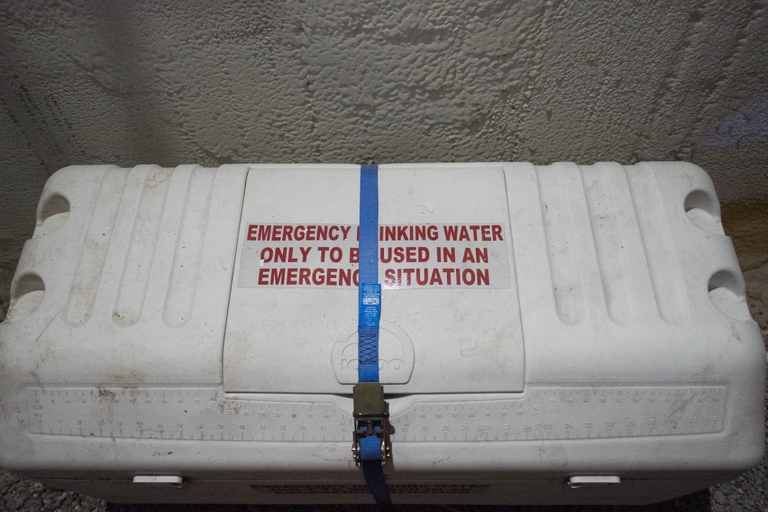La finanza ha la fondamentale responsabilità di traghettare i capitali verso la transizione energetica. Se ne è discusso al Salone del Risparmio 2022.
Nel 2015 i rischi idrici sono costati alle imprese europee 13 miliardi di perdite. Eppure, sono ancora poche a prestare attenzione all’impatto della loro attività sull’acqua.
“Rimettersi al passo coi leader: accelerare la gestione dell’acqua delle aziende in Europa”. È questo il titolo eloquente che l’organizzazione Cdp (per Carbon disclosure project) ha scelto per un suo recente studio “scritto a nome di 634 investitori con 65 miliardi di euro di portafoglio”, come ricorda il sottotitolo. L’obiettivo non poteva essere più chiaro: incitare i grandi gruppi europei a mettere in atto strategie concrete per migliorare la gestione dell’acqua e premunirsi di fronte ai rischi idrici che il cambiamento climatico in corso può generare.
Quando si parla di esposizione di un’impresa al rischio ambientale, si tende sempre a focalizzarsi sulle sue emissioni di gas a effetto serra. “Tuttavia, sappiamo che i rischi legati all’acqua possono spesso essere significativi, come dimostrano i 13 miliardi di perdite legate a rischi idrici dichiarate dalle imprese che hanno partecipato allo studio di Cdp”, sottolinea Antoine Sorange, capo analista Esg della società di gestione francese Amundi, citato nello studio. Le risorse idriche trovano del resto ampio spazio nelle linee guida pubblicate in dicembre dalla Taskforce on climate-related financial disclosures (Tcfd) per incitare le imprese a dare conto nelle loro comunicazioni finanziarie dei rischi ambientali cui devono far fronte e delle strategie adottate.
Un anno fa, nel 2015, Cdp era riuscita a scovare una sola azienda in tutto il vecchio continente con una politica di gestione della risorsa idrica degna di tale nome. Per la cronaca, si trattava della cartiera finlandese Metsä Board. Un anno dopo, la situazione è sicuramente migliorata perché nella lista delle 25 aziende che più si adoperano per la tutela dell’acqua troviamo ben 12 europee tra cui un po’ d’Italia: Fiat Chrysler Automobiles (la cui sede legale si trova però nei Paesi Bassi) si fa notare per come incita fornitori e subappaltatori a ottimizzare il consumo d’acqua e a sviluppare prodotti a basso impatto idrico. Anche la compagnia di utility Enel, pur non figurando nell’olimpo delle migliori aziende europee, è citata nello studio per essere riuscita anzitempo a raggiungere l’obiettivo di ridurre del 10% il suo consumo d’acqua rispetto ai livelli del 2010.
Eppure c’è ancora molto da fare secondo Cdp perché meno della metà delle imprese europee, il 46 percento, per l’esattezza, realizza una valutazione completa dei rischi legati all’acqua. Un misero due per cento in più che nel 2015. E se sono molte quelle che dichiarano di aver identificato opportunità operative, di regolamentazione, giuridiche o di reputazione in una migliore gestione del rischio idrico, sono solo il 42 per cento ad aver attivato strategie per concretizzarle. Del resto, il campione su cui Cdp basa la sua analisi è estremamente parziale dal momento che le 121 aziende che ha potuto contattare sono meno della metà delle aziende europee ritenute esposte a rischi idrici. In Italia, ad esempio, hanno risposto solo tre delle nove aziende contattate. Non pervenuti Luxottica, Leonardo-Finmeccanica, Prysmian (cavi per telecomunicazioni), Terna (gestore della rete elettrica) ma anche alcuni grandi consumatori d’acqua come la compagnia di esplorazioni petrolifere Saipem e il gigante degli idrocarburi Eni. Queste ultime sono del resto in buona compagnia poiché anche le loro omologhe Total e Royal Dutch Shell si sono rifiutate di rispondere. I giganti dell’oro nero non amano parlare di oro blu.
Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.
![]()
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
La finanza ha la fondamentale responsabilità di traghettare i capitali verso la transizione energetica. Se ne è discusso al Salone del Risparmio 2022.
Il Green Deal europeo e i piani di ripresa post-Covid incideranno sulla finanza sostenibile? L’abbiamo chiesto a Davide Tentori, ricercatore dell’Ispi.
Servono investimenti immensi per realizzare gli Sdgs, ma il percorso è tracciato. Ne abbiamo parlato con Francesco Timpano di Asvis.
Il Pnrr potrebbe aprire una stagione diversa per gli investimenti a impatto nel nostro paese. Parola di Giovanna Melandri, presidente di Human foundation e Social impact agenda per l’Italia.
Cos’è un investimento responsabile? Come può il risparmiatore orientarsi in un panorama sempre più articolato? Ecco una breve guida.
La finanza sostenibile cresce, ma il nostro Pianeta resta in crisi. Eurosif, il Forum europeo per gli investimenti sostenibili e responsabili, propone alcune vie d’uscita.
Entro il 2026 l’Unione europea emetterà 250 miliardi di euro in obbligazioni verdi per finanziare le iniziative previste dal piano Next Generation Eu.
La finanza sostenibile crea valore nel lungo periodo, sia per l’investitore sia per il Pianeta e la società. Un approccio che riscuote sempre più successo.
La ripresa post-Covid è un’opportunità da non perdere per rendere più sostenibile la nostra economia. Anche grazie alla finanza etica.