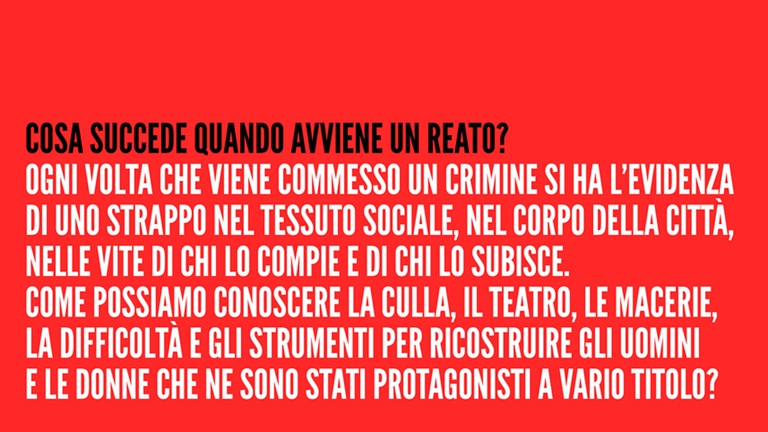Con una sentenza storica, la Cassazione conferma la condanna per il comandante italiano che ha consegnato 101 migranti alla Libia.
Il grado di civiltà di un Paese si misura dal trattamento riservato ai carcerati. La testimonianza di una vittima della strage di Piazza della Loggia: “Non lasciamo i detenuti isolati”, ma accompagniamoli in un percorso di giustizia riparativa.
“Colui che viene condannato viene visto esclusivamente attraverso gli occhi della legge. Viene considerato colui che ha commesso il reato. Ma chi è questa persona? Come mai ha commesso violenza, di qualsiasi tipo, contro qualcuno e contro la comunità? Abbiamo bisogno anche di rispondere a queste domande. Non dobbiamo dimenticare mai che il reo è una persona e non un mostro“. Queste sono le parole di Manlio Milani, un uomo che porta ancora nel cuore la lacerazione improvvisa della strage di piazza della Loggia a Brescia, ovvero la perdita – in quel sanguinoso 28 maggio del 1974 – di sua moglie Livia per mano dei terroristi.
Ascolta “04. Voci dal carcere, quando l’isolamento si trasforma in un ponte” su Spreaker.
Quel giorno, alle ore 10:00, in piazza della Loggia, a Brescia, era prevista una manifestazione contro il terrorismo neofascista indetta dai sindacati e dal Comitato antifascista con la presenza del sindacalista della Cisl Franco Castrezzati, dell’Onorevole Adelio Terraroli del Partito comunista italiano e del segretario della Camera del lavoro di Brescia Gianni Pannella. Centinaia, migliaia di persone erano in piazza a manifestare. Alle 10:12 una bomba contenente almeno un chilogrammo di esplosivo, nascosta in un cestino dei rifiuti, esplose colpendo moltissime persone: tre di queste morirono sul colpo. Una di queste fu Livia. Altre 102 persone rimasero ferite non gravemente.
Nel caso della strage di piazza della Loggia molte cose sono note. Il 20 giugno 2017, la Corte di cassazione conferma la sentenza d’appello che nel 2015 aveva comminato l’ergastolo a Carlo Maria Maggi, il capo del gruppo neofascista Ordine nuovo – un gruppo politico di estrema destra extraparlamentare – nel Triveneto, e Maurizio Tramonte, militante padovano di Ordine nuovo e nello stesso tempo informatore dei servizi segreti. È lui la “fonte” che aveva ispirato una cruciale relazione del centro di Padova del Sid (il servizio segreto militare), datata 6 luglio 1974. In quella relazione si diceva che nel 1974 c’erano state alcune riunioni in cui Ordine nuovo, sciolto l’anno precedente, aveva deciso di riprendere clandestinamente le attività. Uno di questi incontri era avvenuto ad Abano Terme il 25 maggio. Ovvero tre giorni prima della strage di piazza di Brescia.
La strage di piazza della Loggia ha, quindi, dei responsabili. Maggi e Tramonte sono i colpevoli materiali della strage.
I mandati, però, e molte altre sfumature di quella terribile vicenda, sono rimaste nell’ombra sia dei processi che della memoria collettiva. Fare memoria e renderla attiva, una memoria dello Stato e soprattutto dei cittadini. È per questo che è nata nel 2000 l’Associazione casa della memoria di Brescia, di cui Manlio Milani è presidente.
Si è scelto di guardare all’interno del carcere, facendosi guidare dalla voce e anche dallo sguardo di Milani. I suoi occhi e le sue parole infatti aprono una breccia nelle sbarre che separano chi sta dentro da chi sta fuori, all’interno degli istituti di pena, e mettono al centro l’umanità condivisa da vittime, rei e dalla società, che non deve porsi come cesura, ma come trait-d’union. “Il detenuto è una persona che parla a tutti noi, perché la violenza apre uno strappo non solo nel cuore della vittima, ma – continua Milani con una voce profonda – pone delle domande sulla lacerazione avvenuta in seno all’intera società che ha subito quel crimine”.
Il carcere ha quindi la forma di una parte della risposta alla domanda che ogni crimine pone alla società civile. Un reato è lo specchio di un qualche disagio che c’è nella società.
“Ai detenuti va ridata fiducia, perché possano riconoscere il male fatto anche attraverso il dialogo diretto con la vittima. Anche la vittima – conclude Milani –, quando comprende che il reo ha preso consapevolezza del male, della lacerazione, si rende conto di non aver a che fare con un mostro ma con una persona”.
Leggi anche: Che forma può assumere la libertà in carcere: come il lavoro rieduca alla cultura
“Quando sei un criminale non dai valore alla tua vita e come fai a vedere il valore di un’altra persona, dell’essere umano, della vita o della vittima addirittura? Te ne freghi, perché sai che il tuo primo valore è vivere, cercare di sopravvivere, e se non hai le condizioni o le capacità non puoi vedere mai una vittima o anche un essere umano nella vittima che stai rapinando”. Queste, invece, sono le parole del detenuto Carmelo nel docufilm Lo strappo. Quattro chiacchiere sul crimine.
Questo docufilm nasce dall’esperienza e dalle riflessioni di quattro testimoni del contrasto alla scelta criminale, esito di più di 20 anni di attività professionali: Angelo Aparo, psicologo nelle carceri milanesi; Francesco Cajani, magistrato; Carlo Casoli, giornalista; Walter Vannini, criminologo.
L’obiettivo de Lo strappo è, in primo luogo, mostrare il punto di vista di ciascuno sulle altre parti in causa, la vittima, il reo, i mezzi d’informazione e la giustizia, dimostrando come ciascuna parte sia legata per molti fili all’altra: allo stesso modo in cui lo è ognuno di noi, estraneo ai fatti eppure parte della medesima narrazione e del medesimo tessuto sociale, consapevole o no.
In secondo luogo, Lo strappo intende restituire una visione del reato il più possibile aderente alla realtà delle cose che possono accadere a ciascuno di noi, immortalate nella loro naturale sequenza: la culla, il teatro, le macerie, la difficoltà e gli strumenti per ricostruire gli uomini che ne sono stati protagonisti a vario titolo.
Leggi anche: InGalera, il primo ristorante gestito dai detenuti che apre le porte del carcere ai cittadini
Il risultato è un percorso documentaristico all’interno del quale i componenti del comitato scientifico, pur avendo di fatto materialmente condotto le interviste a tutti i protagonisti di questo racconto, rimangono volutamente senza volto e senza voce. Ponendo a tutti le stesse domande, dopo essersi fatti loro stessi interrogare, nel corso del loro percorso professionale, dalle proprie.
L’obiettivo di questo reportage sul carcere non è quello di descrivere i numeri delle carceri italiane, ma quello di sollecitare alcune riflessioni, di fotografare in modo sintetico, e il più possibile esaustivo, la complessità dell’evento “reato” in tutte le sue molteplici implicazioni: psicologiche, sociologiche, emotive. Implicazioni che riguardano tutti i soggetti coinvolti sia antecedentemente, sia durante, sia successivamente all’agire criminoso.
Chi finisce in carcere e perché? “Finiscono nei penitenziari le persone che hanno dentro una forte rabbia, un grande rancore. In carcere finiscono soprattutto le persone che fanno diventare azione di rivalsa verso l’altro e verso il mondo la loro rabbia nei confronti della società”. Queste sono le parole con cui risponde lo psicologo Angelo Aparo, uno degli ideatori de Lo strappo, che nelle carceri milanesi ha fondato nel 1997 il Gruppo della trasgressione, un gruppo di confronto e dialogo all’interno degli istituti di pena tra i detenuti stessi e con la società civile, che entra in carcere per far sentire chi è dentro, parte di ciò che sta fuori.
Quando si sta in mezzo a questo gruppo, si riesce a toccare con mano quanto spiegato dal dottor Aparo. Il Gruppo della trasgressione lavora sull’auto-percezione di chi commette reati e sul sostrato affettivo che anche nelle persone comuni può portare a piccole violenze sugli altri e su se stessi.
Il gruppo comprende oggi un’associazione e una cooperativa strettamente connesse, entrambe costituite da detenuti, ex detenuti, imprenditori, professionisti, studenti universitari e neolaureati.
I principi e gli obiettivi che da sempre caratterizzano tale attività sono lo scambio fra dentro e fuori, la partecipazione alla vita della comunità, il lavoro su se stessi, l’educazione alla legalità, la prevenzione di bullismo e tossicodipendenza.
In carcere infatti bisogna innanzitutto promuovere nel detenuto quella riflessione che non c’era al momento del reato, per recuperare la coscienza della parentela fra il reo e la vittima, l’appartenenza alla stessa comunità.
Un modo per dare impulso a questo riconoscimento di un’umanità di fondo che irrora vittime e rei, sono i percorsi di giustizia riparativa.
Nell’immaginario collettivo e per una questione di scarsa informazione, non c’è nessuna idea del fatto che in carcere si possa fare anche un percorso di riabilitazione, che si debba fare un percorso. Che la pena è questo. Che non è un caso che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.
Leggi anche: Opera, il teatro entra in carcere come agente di trasformazione
L’obiettivo della giustizia riparativa è quello di rispondere all’esigenza di restituire attenzione alla dimensione personale e sociale che investe il crimine, senza la quale la pena altro non sarebbe che un’afflizione.
La giustizia riparativa viene tematizzata per la prima alla fine degli anni Ottanta in Nordamerica (restorative justice) e nasce come un modello sperimentale in cui viene proposta una sorta di equazione per la quale “il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali; le violazioni creano obblighi; l’obbligo principale è quello di rimediare ai torti commessi“.
Di fatto questa è una rivoluzione copernicana, un cambiamento di paradigma. La pena non deve essere più retributiva, dove la sanzione penale deve servire a punire il colpevole per il male provocato, ma riparativa. Le persone – vittime e rei, con le loro esperienze, il vissuto, le esigenze e le relazioni – non rimangono del tutto marginali come nel paradigma precedente, ma diventano centrali.
I percorsi di giustizia riparativa sono diretti a tutte le parti coinvolte, vittima, reo, società civile, e la direzione che dovrebbe essere intrapresa per recuperare un’umanità sofferente che affolla le nostre carceri, la indica Milani: “non lasciare i detenuti isolati, per poter fare in modo che essi da un lato cerchino di recuperarsi ad una nuova vita, e dall’altro lato trovino la possibilità di sopportare fino in fondo, pur vivendo quella colpa, il peso delle loro azioni. Che così non è un’espiazione, è semplicemente riconoscere la responsabilità di ciò che hanno prodotto”.
Lo sforzo, il compito che Manlio invita a compiere, allora, è quello di indirizzare chi patisce lo strappo, il dolore del reato, verso il bisogno che dal dolore nasca qualcosa. E questo sforzo va orientato in una direzione che non può essere quella dell’odio perché nel tempo, e ce lo ha raccontato lui da vittima, si capisce che la prigione dell’odio consuma la vita di una persona e di una comunità. Senza restituirle nulla.
Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.
![]()
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Con una sentenza storica, la Cassazione conferma la condanna per il comandante italiano che ha consegnato 101 migranti alla Libia.
Numerose ong hanno sottolineato la situazione drammatica della popolazione palestinese a Gaza, chiedendo a Israele di rispettare il diritto umanitario.
Vida Diba, mente di Radical voice, ci parla della genesi della mostra che, grazie all’arte, racconta cosa significhi davvero la libertà. Ed esserne prive.
L’agenzia delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva (Unfpa) e il gruppo Prada hanno lanciato un programma di formazione per le donne africane.
Amnesty International ha pubblicato un manifesto elettorale in 10 punti rivolto ai partiti italiani: “I diritti umani non sono mai controversi”.
Si tratta di Zahra Seddiqi Hamedani ed Elham Choubdar colpevoli, secondo un tribunale, di aver promosso la “diffusione della corruzione sulla terra”.
Dal 2 al 4 settembre Emergency ricorderà che la pace è una scelta realmente perseguibile a partire dalla conoscenza e dalla pratica dei diritti umani.
Le persone transgender hanno ora il diritto alla piena autodeterminazione a Milano grazie al primo registro di genere in Italia.
In Somalia un gruppo di coraggiose giornaliste somale ha deciso di aprire una redazione interamente femminile, Bilan, sfidando gli stereotipi.