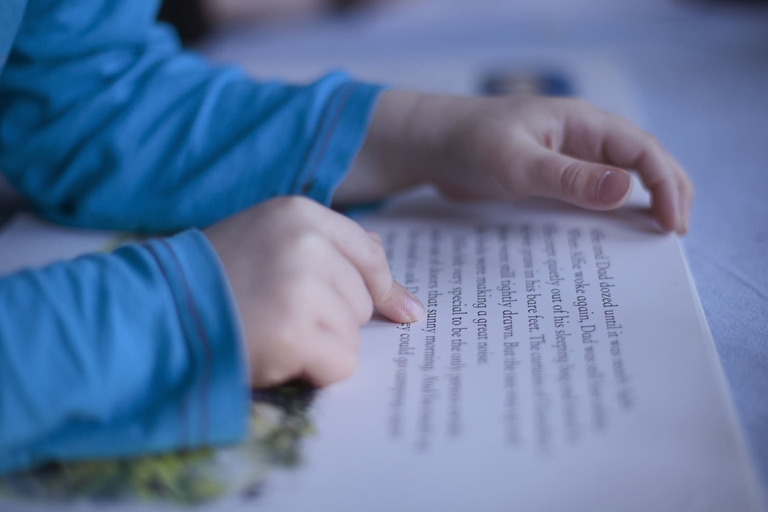Il plasma di Harrison conteneva l’anticorpo Anti-D, capace di prevenire la malattia emolitica del feto.
La maggior parte delle persone è convinta che l’empatia – la capacità di mettersi nei panni degli altri – sia innata, ma non è così. L’empatia può essere insegnata. Si parla di apprendimento socio-emotivo e, dai primi Duemila, la sua popolarità è cresciuta nelle scuole di tutto il mondo – Danimarca e Stati Uniti tra i
La maggior parte delle persone è convinta che l’empatia – la capacità di mettersi nei panni degli altri – sia innata, ma non è così. L’empatia può essere insegnata. Si parla di apprendimento socio-emotivo e, dai primi Duemila, la sua popolarità è cresciuta nelle scuole di tutto il mondo – Danimarca e Stati Uniti tra i pionieri – anche in risposta all’aumento tra i ragazzi di episodi di violenza, bullismo e dipendenze.
Ulisse Mariani, psicologo e psicoterapeuta, ricercatore e autore di libri, da quindici anni si dedica alla ricerca sull’educazione emotiva, conducendo sperimentazioni in varie parti d’Italia. Con la collega Rosanna Schiralli ha ideato il metodo della Didattica delle emozioni, un format validato scientificamente per educare all’intelligenza emotiva gli alunni fra i tre e i 18 anni. “Non si tratta di educare i sentimenti, ma di incidere in profondità sui nuclei nervosi del cervello dei nostri figli, affinché essi possano svilupparsi nel miglior modo”, spiega Schiralli. A febbraio a Viterbo sette istituti hanno firmato un accordo per aderire al metodo. È nata la prima rete di Scuole dell’empatia.
Dottor Mariani, in cosa consiste la rete?
La rete delle Scuole dell’empatia comprende quelle scuole in cui i docenti si sono formati secondo il metodo della Didattica delle emozioni e che hanno ottenuto la certificazione per il proprio istituto. Sono persone che hanno scelto di applicare in classe le strategie e le attività per insegnare a bambini e giovanissimi a identificare, modulare e gestire il loro mondo emozionale. È una competenza ritenuta da tutte le agenzie scientifiche internazionali (compresa l’Oms) la migliore e più utile per crescere in modo sano, incrementando autonomia, autostima ed empatia e contribuendo a proteggere da situazioni di rischio e disagio.
A che punto è il progetto?
È già cominciato. Oltre a Viterbo, Grosseto, Udine e Aquileia stiamo ricevendo richieste da parecchi istituti da Roma, a Brindisi, da Todi a qualche scuola ligure e marchigiana. L’impresa non è facile, perché siamo in controtendenza con un sistema scolastico che privilegia ancora altre competenze. Quello che veramente ci manca è l’empatia, il mettersi nei panni degli altri. E questo deve essere insegnato fin da quando siamo piccoli. Sono convinto che se questo progetto ramifica, otterremo dei grandi risultati.
Cosa c’entra l’empatia con la prevenzione di condotte a rischio come bullismo o dipendenze?
Ho lavorato 41 anni in un centro Sert (Servizi per le tossicodipendenze) a Viterbo. Arrivavano ragazzi sempre più giovani, anche di 13-15 anni. Ad un certo punto hanno cominciato a chiedermi di fare le prime consulenze per overdose di cocaina in pediatria: è stato lì che ci siamo chiesti come fare prevenzione allenando l’empatia. Il concetto è mutuato dal libro “Intelligenza emotiva” di Goleman, ma anche dalle scoperte degli anni novanta sui neuroni specchio fatte da Rizzolatti a Parma, che sono la base biologica dell’empatia. Questo vuol dire che se noi forniamo ai nostri figli, fin da quando sono piccoli, addirittura sotto i tre anni, nell’infanzia, nella preadolescenza e nell’adolescenza, le modalità per trasformare gli impulsi in emozioni o in azioni adattive, questo rappresenta il miglior fattore protettivo per non incorrere nei pericoli della droga, della violenza, delle condotte disfunzionali alimentari e tutto il disagio di cui soffrono appunto i giovani di oggi. Si attivano dei canali di comunicazione empatici che pian piano costruiscono una capacità interna di modo che, quando i bambini sono grandi preferiscono “drogarsi delle proprie emozioni” invece che con sostanze esterne.
Così siete arrivati al metodo della Didattica delle emozioni…
Attraverso specifiche tecniche, messe a punto dopo anni di test psicologici validati, qualsiasi insegnante ha la possibilità di attivare questi canali. Qui a Viterbo abbiamo una nostra collega che oltre ad essere una psicologa è anche docente in una scuola primaria. E se tu entrassi in questa classe, sembra di stare su un altro pianeta. Quando c’è una lite i ragazzi chiedono: “Maestra, abbiamo cinque minuti per risolvere il problema?”. Poi si dispongono in cerchio, appoggiano la mano sulla fronte l’uno dell’altro per sentire quello che l’altro sente e in pochi minuti risolvono il conflitto nel modo costruttivo, pronti a ritornare al loro posto e a riprendere la lezione.
Quindi non esiste una vera e propria “ora di empatia”…
No, sono tecniche trasversali di supporto all’insegnante. Un esempio è l’appello delle emozioni, al quale si risponde invece con un numero da uno (sto male) a dieci (sto benissimo). Oppure i cartellini delle emozioni, dallo smile alla faccina triste: i bambini hanno subito preteso che anche bidelli, direttrice e insegnanti li portassero. Sono molto attaccati a questo modo di fare scuola. È trasversale a tutte a tutte le età per tutte le materie per tutte le classi. Le tecniche sono facilissime. Sono state costruite per essere quasi preverbali, per essere meno razionali e più emotive possibile: in questo modo si attivano i neuroni specchio dell’empatia. E si contribuisce al benessere della persona.
Ci spiega come funzionano i neuroni specchio?
Costituiscono la base biologica dell’empatia. Si tratta di quei neuroni motori specializzati che riescono a sentire quello che l’altro sente e a percepire addirittura il movimento dell’altro pur rimanendo fermi. Per intenderci, sono quei neuroni che si attivano quando, ad esempio, vediamo qualcuno farsi male alla gamba durante una partita di calcio e proviamo un senso di fastidio alla gamba. È una competenza che abbiamo sviluppato solo noi umani in tempi relativamente recenti dal punto di vista evolutivo, ciascuno con diverse gradazioni, non è innata: i neuroni specchio devono essere educati, devono essere sollecitati.
Allora è vero che l’empatia si può imparare…
Certo. Pensiamo a Mozart: suonava il clavicembalo a cinque anni ma se fosse nato in una famiglia dove questo strumento non c’era , probabilmente non sarebbe diventato uno dei più celebri compositori della storia. E poi attenzione, essere empatico non vuol dire generoso, buono: vuol dire sapersi mettere nei panni dell’altro, sentire quello che l’altro sente. Esiste anche l’empatia nera, di coloro che percepiscono con forza e piacere la sofferenza altrui. Per questo dico che l’empatia va costruita, allenata, indirizzata.
Oltre alla prevenzione di condotte negative, le vostre scoperte scientifiche parlano di promuovere il benessere. In che senso?
Con l’Ateneo San Raffaele di Milano, l’Università dell’Aquila, la Federico II di Napoli e il Centro internazionale di biotecnologie avanzate, abbiamo indagato quello che succede nel cervello dei ragazzi che partecipano al nostro progetto. Lavorando sempre con un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo, i biologi di queste università hanno prelevato un campione salivare dai bambini di sette anni: ne è risultata un’evidenza scientifica straordinaria, un calo notevole del cortisolo. Questo significa meno stress, significa che le cellule nervose del cervello crescono meglio. Significa un sistema immunitario più efficiente, la riduzione di condotte aggressive e di bullismo, il miglioramento del rendimento scolastico e persino della concentrazione. Evidenze biologiche alla mano, siamo arrivati alla costruzione dell’empatia, e questa è stata una grande scoperta che ha fatto un po’ subito il giro del mondo.
Pensa che l’uso di device digitali a scuola possa influire in qualche modo sulla costruzione dell’empatia?
Che i bambini sotto i dieci anni siano sovraesposti al digitale è sotto gli occhi di tutti. Credo sia ancora presto per conoscere l’impatto che questa esposizione ha sulla loro crescita socio-emotiva. Quel che è certo è che il nostro cervello è plastico e noi siamo gli architetti di questo cervello. Quindi visto che il digitale ti consente, con un minimo sforzo, di ottenere il massimo risultato in modo quasi passivo, alcune parti del cervello rischiano di non svilupparsi appieno.
Lo sostiene anche Marianne Wolf, neuroscienziata di fama mondiale secondo cui per costruire l’empatia la lettura di un libro cartaceo vale più di mille video.
Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.
![]()
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Il plasma di Harrison conteneva l’anticorpo Anti-D, capace di prevenire la malattia emolitica del feto.
Dopo l’Australia, in Italia prende vigore l’appello al governo per proibire gli smartphone prima dei 14 anni e i social prima dei 16. Le ragioni dei primi firmatari, Daniele Novara e Alberto Pellai.
Un anno dopo l’introduzione della Ulez, l’enorme Ztl a traffico limitato, Londra centra gli obiettivi. “Camminare previene l’obesità” spiega l’esperta Cristina Xiao.
Cosa sono, davvero, le cure palliative? In questo articolo, Vidas fa chiarezza e spiega in cosa consiste la campagna OGGI.
Questo sapere medico millenario, arrivato dal Tibet, è ancora vivo. I rimedi naturali vengono prodotti in un piccolo paese alle pendici dell’Himalaya.
Una clinica online, integrata con l’intelligenza artificiale, dedicata ai disturbi alimentari: così Comestai risponde alle difficoltà di accesso alle cure.
Tre Americhe, otto amici e un obiettivo: raccogliere fondi per l’hospice pediatrico Casa sollievo bimbi di Vidas
Per le cure palliative dei più piccoli è fondamentale avere un’equipe preparata. Ne parliamo con William Polito, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (Tnpee).
“Il cibo sia la tua medicina”, diceva Ippocrate, e le scoperte emerse in tempi recenti tra alimentazione sana e salute dicono molto della natura profetica di questo detto. In particolare, il ruolo della nutrizione nella prevenzione delle malattie sembra essere ancora più decisivo se l’alimentazione sana e variata è introdotta sin da piccoli: una dieta