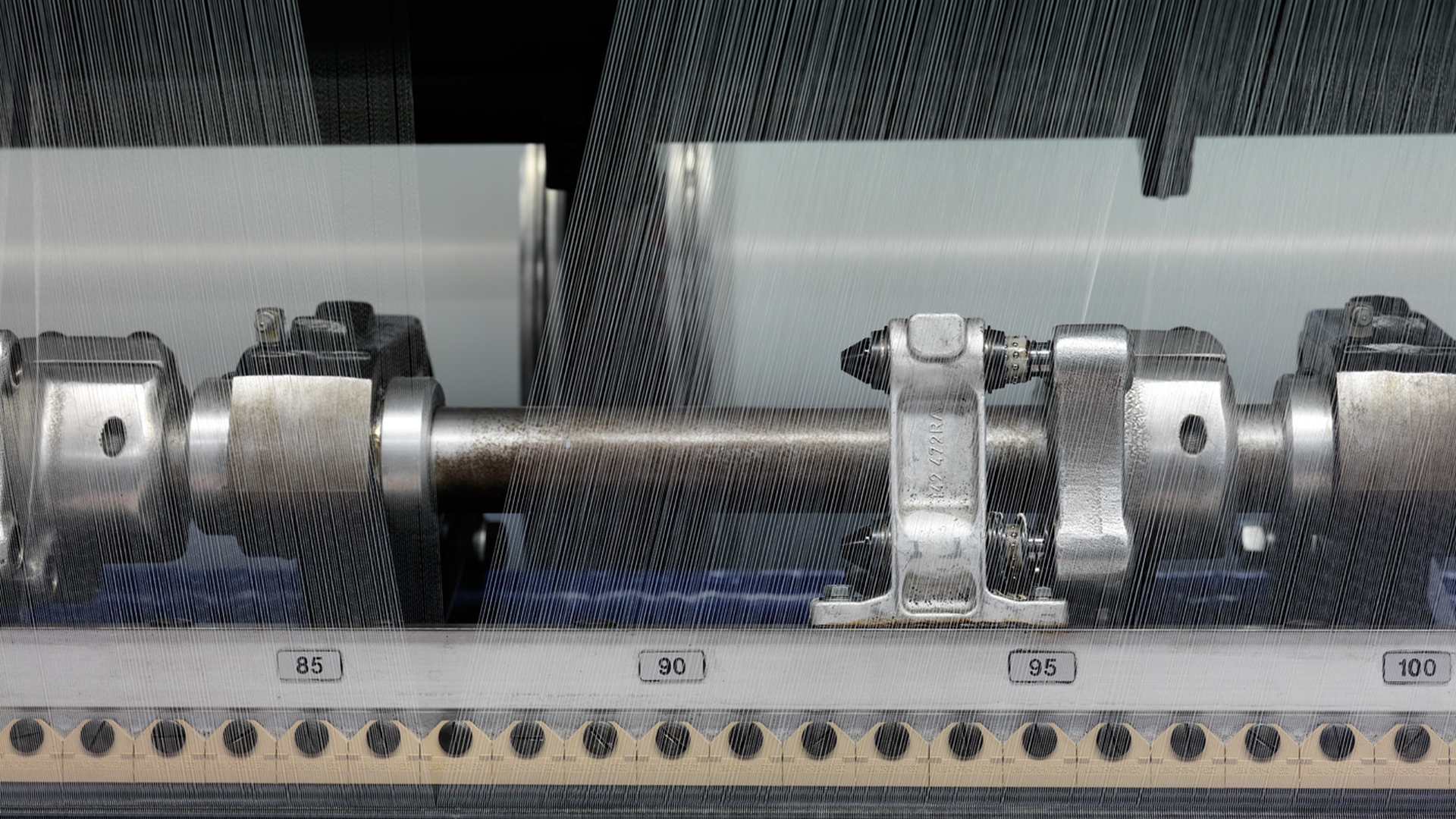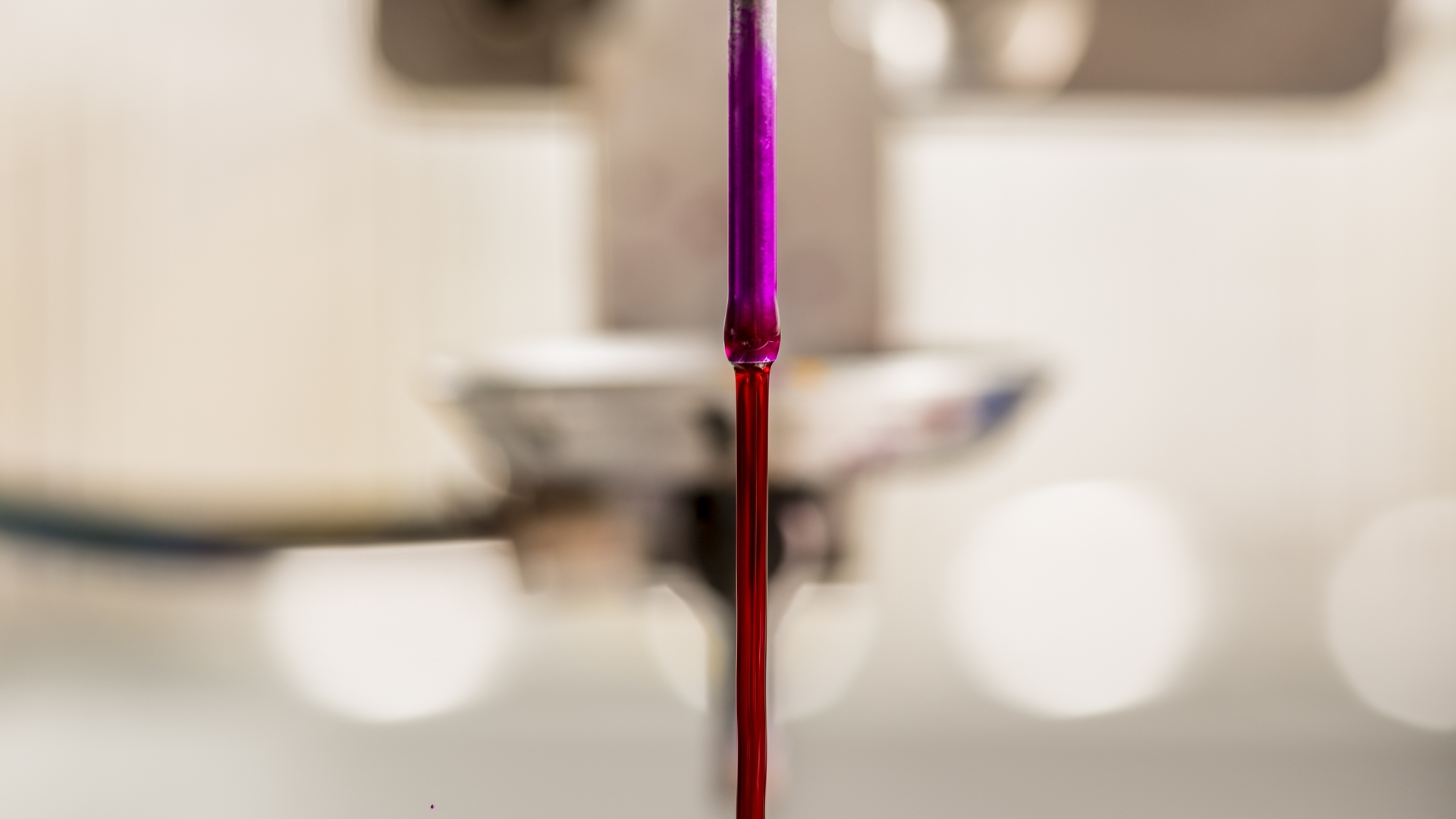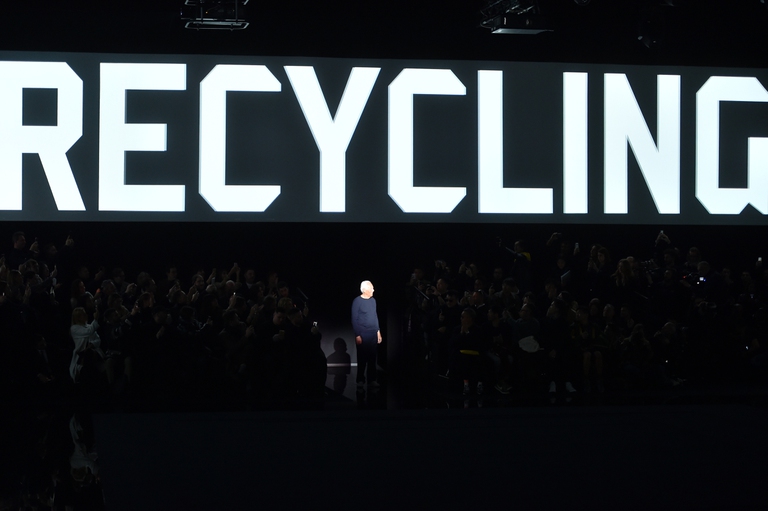10. Digitalizzazione: ora o mai più
La pandemia causata dal virus Sars-Cov-2, con la conseguente quarantena e il blocco della mobilità e di tutte le attività, ha spinto molti brand di moda a “rifugiarsi” nell’e-commerce come strumento imprescindibile per far fronte alla chiusura degli store, dei negozi “reali”. Una tendenza confermata dai numeri: un’indagine di McKinsey condotta in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, ha rilevato che il 24 per cento delle persone ha acquistato per la prima volta un prodotto online durante la quarantena, e il 76 per cento di queste persone si è dichiarato soddisfatto. Un aumento degli acquisti online sembra dunque scontato, anche quando la crisi sarà superata. Quest’ultimo dato, infatti, suggerisce che una percentuale delle vendite “offline” potrebbe migrare permanentemente verso lo shopping digitale, soprattutto perché la diffidenza dei consumatori nel recarsi fisicamente nei negozi è alta. Le aziende digitalmente più pronte superavano i concorrenti che non avevano sviluppato solide capacità digitali già prima dell’emergenza sanitaria. La Covid-19 ha allargato ulteriormente questo divario e accelerato il processo di digitalizzazione per chi ha capacità e volontà di investire. Ma per digitale non si intende solo un canale di vendita. La digitalizzazione può aiutare le case di moda ad adattarsi e rendere ogni fase della catena del valore migliore, più rapida, economica. Più efficiente. La digitalizzazione, ad esempio, può suggerire nuove opzioni logistiche, facilitare la ricezione degli ordini e le consegne e stimolare nuovi metodi di acquisizione dei clienti. Lungo la supply chain aiuta a prevedere e gestire l’inventario. Non banale se si considera che la direzione in cui si sta andando è quella delle collezioni on demand, come vedremo meglio in seguito. “Il digitale può essere uno strumento utile a progettare le collezioni in modo virtuale evitando sprechi nelle fasi di sviluppo – ci spiega Giorgio Ravasio, country manager di Vivienne Westwood Italia -, soprattutto per evitare la realizzazione di capi commercialmente non efficaci. C’è molto da fare in questo ambito. Del resto il nostro settore è culturalmente manifatturiero, fisico, materiale. Ma certamente si farà. È una grande sfida e anche una grande opportunità”. La questione più ostica – e che coinvolge tutti i settori – riguarda il rapporto tra tecnologie digitali e posti di lavoro. Alcune mansioni rischiano di scomparire, altre prima inesistenti hanno fatto la loro comparsa, altre ancora hanno subito profondi cambiamenti. E queste ultime forse sono più di quante si pensi: un rapporto del Joint Research Centre, il servizio scientifico interno della Commissione europea, evidenzia che il digitale influisce più sui compiti che sull’occupazione: non si limita a creare o distruggere posti di lavoro, ma cambia ciò che le persone fanno e, soprattutto, come lo fanno. Si pensi per esempio all’introduzione del computer che portò molti impiegati ad adattarsi a nuovi metodi di lavoro, sollevandoli da compiti spesso routinari in favore di competenze sociali. Tuttavia, dal rapporto emerge che un terzo della forza lavoro dell’Unione europea ha scarse – o non ha affatto – competenze digitali. La cui domanda sta crescendo vertiginosamente.